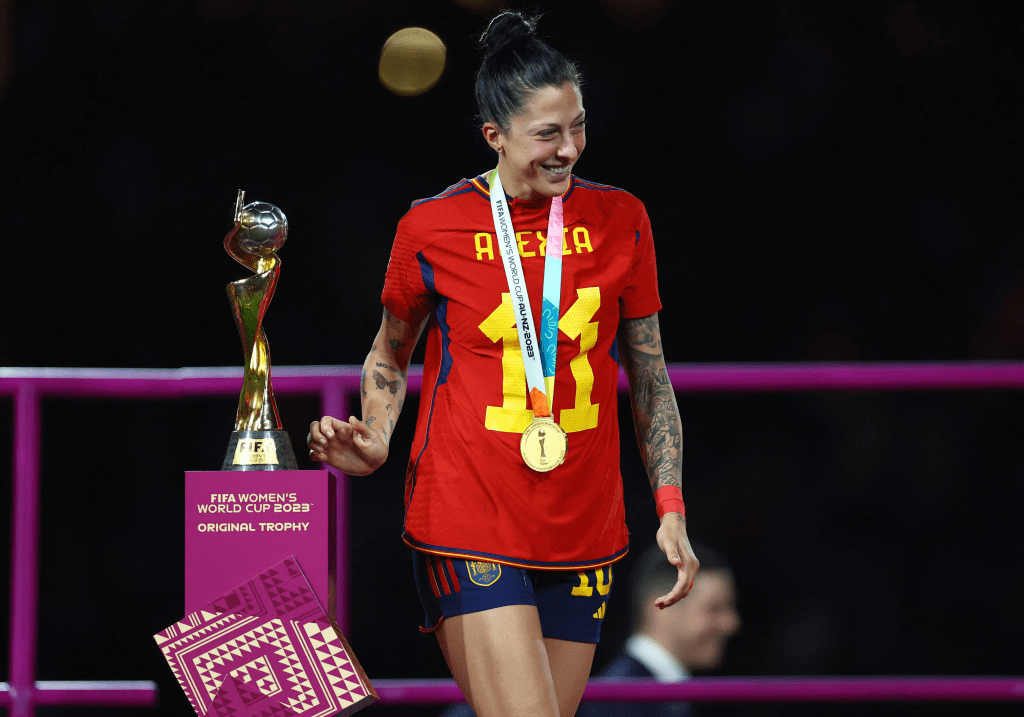Traduco in fretta, ma volentieri, questo articolo necessario di Gemma Herrero, sull’ambiente in cui devono lavorare le giornaliste sportive.

Nel corso dell’ultima settimana, mi è risuonata un’idea in testa senza sosta, senza tregua. E poi le domande. Come è stato possibile arrivare a questo punto? Com’è successo che noi della stampa sportiva non abbiamo denunciato a sufficienza le azioni di Rubiales e compagnia? Come abbiamo potuto tollerare, normalizzare, applaudire, reggere il gioco quando c’erano tanti segnali allarmanti, sotto gli occhi di chiunque? Come abbiamo creduto con tanta facilità al discorso sulle quindici giocatrici giudicandole delle bambine viziate, capricciose, maleducate, ricattatrici, e lo abbiamo diffuso generando una condanna generalizzata nei loro confronti? In definitiva, come abbiamo potuto lasciarle sole, e soprattutto perché? E la risposta arrivava chiara, spietata, secca: perché anche nella stampa sportiva ci sono tanti Rubiales. Per questo non le abbiamo sapute raccontare, perché i muri, i pregiudizi maschilisti – se non misogini – si trovavano, si trovano, anche nelle redazioni.
Quelli che ci hanno toccato e baciato senza permesso né consenso, e il giorno dopo ci hanno informato, avvertito, che non era niente di grave, non esagerare e non ingrandire le cose. Quelli che ti hanno mandato messaggi vocali spiegandoti quanto gli piacevano le tue tette, e dopo fanno finta che non si ricordano, che non è successo proprio niente, e con costoro continui a condividere spazi di lavoro. Questi altri che ora sono famosi, e qualche anno fa ti chiedevano il numero di telefono per passarlo a un giocatore “perché vuole parlare con te e che ti costa, che fa”, questi che spiegavano ad alta voce nell’autobus che ci portava allo stadio come si erano divertiti la notte precedente andando ‘a puttane’, ed era tanto divertente, tutti ridevano, quelli che annunciavano guardando l’orologio che restavano un po’ di più in redazione perché così arrivavano a casa quando i loro figli avevano già fatto il bagnetto e cenato.
Quelli che si indignavano quando gli facevi notare che avevano comportamenti maschilisti, perché loro non hanno ucciso né picchiato nessuno, e come osi dire questo a me, che ho una madre, una moglie e delle figlie. Quelli che indicavano te come una donna acida, una pazza, stai dando i numeri. Quelli che ti davano una bella ripassatina con gli occhi, da capo a piedi. Quelli che quando ti salutavano stringevano più del dovuto. Quelli che ci hanno relegato ai nostri posti di lavoro e ci hanno ammonito perché abbassassimo il tono, perché stai esagerando, calmati, non ti arrabbiare. Quelli che hanno condiviso sui loro social foto di giornaliste con la bocca aperta in una chiara allusione sessuale, e ancora hanno colonne sui giornali, e spazio nei mezzi di comunicazione generalisti perché era uno scherzo, perdio. Quelli che non hanno mai te come punto di riferimento, come modello da imitare, e non ti citano né ti menzionano, ma in compenso si dedicano grandi elogi tra loro. Quelli che addirittura sono arrivati a imitarti, burlandosi di te, in un programma in diretta TV. Quelli di cui parliamo quando noi, le donne, le giornaliste, ci riuniamo per infonderci forza, trasmetterci calore, comprensione, amore, compagnia, affetto, quando ridiamo, ci liberiamo e iniziamo a fare una lista coi loro nomi per avvertirci tra di noi.
Soprattutto, quelli che non abbiamo denunciato perché come ti vai a mettere in guai del genere, non ti crederanno, dovrai dare tante di quelle spiegazioni su cosa ci facevi tu con un bicchiere di troppo, e questa storia ti perseguiterà per sempre. Se già lo sapevi che il giornalismo sportivo era così, perché ti impegoli. O ti ci abitui o non ti lamenti, non parli, taci. Perché non sarai mai più solo una giornalista, ma quella che ha denunciato, e per tutta la vita ti perseguiterà uno stigma, ti sbatteranno le porte in faccia, non ti assumeranno. Porterai la nomea di problematica, esagerata, pazza, mentre loro fanno i padroni, hanno incarichi con nomi lunghi in inglese, fanno carriera e si proteggono tra loro perché niente di ciò che fanno è in malafede, non fare così, che basta una denuncia di queste e gli rovini la vita con la tua testa calda. Il patto tra gentiluomini, l’omertà. Quelli che… not all men, che invece di mettersi dalla tua parte si impegnano a sottolineare che in fondo l’altro è un brav’uomo, un po’ pesante è vero, uno che fa tanti errori, ma una brava persona. Quelli che dubitano della tua parola, della tua esperienza, quelli che la sottovalutano, quelli che sono incapaci di provare empatia, di comprendere l’effetto che ha su di te, sulla tua autostima, sulla tua salute fisica e mentale, e continuano a farti sapere che hai la pelle troppo fina, la devi indurire di più e meglio. Perché, vediamo un po’, cos’è che ti sarebbe successo? Di cosa ti lamenti esattamente?
Non è la prima volta che racconto, che scrivo, che arrivai a Barcellona un settembre, e tre mesi dopo, quando ancora mi stavo ritagliando il mio spazio e stavo conoscendo la città, il lavoro e i miei colleghi, il Barça celebrò una cena di Natale e mi toccò sedermi al tavolo con un dirigente con cui non mi ero mai incrociata, e che passò tutto il tempo a fare commenti sessisti, presunti scherzi, doppi sensi, davanti ai quali i miei colleghi si scompisciavano: commenti tipo che era una buona cosa avere delle donne giornaliste, perché potevi far cadere a terra il tovagliolo e te l’avrebbero succhiato sotto il tavolo. Addirittura mimò la cosa a gesti. Lo shock e il mio desiderio di far parte dell’ambiente, di non rovinare tutto dall’inizio, mi spinsero a tacere in un primo momento. Sedute al tavolo c’eravamo due donne, due giornaliste, e quando l’altra dopo la cena si alzò per registrare il discorso del presidente, il dirigente se ne uscì con: “Che tette!”. E tutti risero. A quel punto esplosi ed esclamai, furiosa, che quando la mia collega tornava al tavolo doveva dirglielo in faccia. Il silenzio fu brutale. Il presidente cominciò in quel momento a parlare e, dopo aver terminato, un giornalista, uno solo, mi disse nell’orecchio: “Qui non siamo tutti così”. Il resto se ne andò senza salutarmi e la mia sensazione fu che avevo sbagliato. Io. La guastafeste. Si stavano divertendo così tanto…
Questa storia l’ho spiegata diverse volte in pubblico, e aspetto ancora che i miei colleghi mi chiedano scusa. So che gli è arrivata, so che mi hanno sentita, so che mi hanno letto, so che si sono avvertiti tra loro. E nessuno è stato capace di esprimermi in privato né le sue scuse né, ovviamente, nessun rimorso per quanto fosse successo, vent’anni dopo: il tempo non gli è mancato. Adesso già li vedo, li ascolto e li leggo mentre pontificano dai loro rispettivi spazi sul maschilismo, sull’avanzare del femminismo, sull’abuso di potere, sul patriarcato e sul sistema arcaico della Federazione spagnola di calcio che ha sostenuto Rubiales. Solennemente indignati.
Due anni fa, Maria Tikas ha pubblicato un reportage su Sport intitolato “Le giornaliste dicono basta”, in cui quindici giornaliste sportive – tra cui c’ero anch’io – raccontavano le mancanze di rispetto, gli abusi, gli insulti e le minacce che facevano parte della nostra vita quotidiana e che erano visibili, ben visibili, sui social. Quindici, che coincidenza. Le nostre esperienze erano identiche, dei veri e propri calchi, ma non è successo nulla. Qualche messaggio privato e pubblico qua e là, e molti silenzi, perché per i più non era niente di clamoroso; già sai come sono i social, anche agli uomini succede. Puttane, zoccole, non sai di cosa parli, non sai un cazzo, sei un’incapace e sei lì grazie a tuo marito, perché sei raccomandata, per le tue tette, per i capelli lunghi, perché lo stai succhiando al capo, che ne sai tu, grassona, spaventapasseri, vecchiaccia, ragazzina, scema. Insulti senza alcun dubbio misogini e maschilisti che sono stati, in generale, ignorati del tutto. Erano il prezzo che bisognava pagare.
Ambienti maggioritariamente maschili o mascolinizzati – con tutto ciò che questo comporta, uomini bianchi eterosessuali che da anni si applaudono tra loro ed espellono dall’ecosistema qualsiasi dissidenza. Quelli che fanno gli offesi quando li accusi, e poi i complici silenziosi, necessari per sostenere una struttura tossica, che adesso cercano di mantenere la loro patina di dignità. Quelli che applaudirono al grido di “sono con te” a Rubiales, nella notte degli sfigati e degli imbecilli totali. Quelli che il lunedì, dopo le scuse inaccettabili nelle quali il presidente della Real Federazione Spagnola di Calcio si stava giustificando, volevano già chiudere il caso perché “ha chiesto scusa e questo gli fa onore”, e che ancora sostenevano che il gesto in sé era una sciocchezza e la caccia alle streghe che si era sollevata era uno scandalo. Quelli che da un giorno all’altro, abracadabra, hanno sviluppato una coscienza femminista. Quelli che fingeranno ancora di non leggermi, quelli che risponderanno irritati a questo articolo esigendo che faccia nomi, perché altrimenti ne escono tutti infangati, che vergogna, che modi sono, che prove avrei?
Quelli che ti incitano a scrivere arrabbiata perché così lo fai meglio, senza rendersi conto, senza che gli importi il tuo logorio fisico e mentale. Perfino quelli che hanno bisogno della femminista di guardia al loro fianco perché poveretti, loro non sanno, è che li disegnano così, ed è uno sforzo titanico capire, leggere, ascoltare, rivisitarsi, e non hanno nessuna cazzo di voglia di guardarsi allo specchio perché in fondo molti sanno che sì, che sono così anche loro, e decidono consapevolmente di fregarsene. Quelli che torneranno oggi alle redazioni dove la presenza femminile è scarsa o inesistente, senza nessuna prospettiva di genere, e torneranno a spiegarci tutto, di nuovo. E non è finita, no. Magari lo fosse. Così che, alla fine, torno all’inizio, alla domanda martellante che mi perseguita da giorni: come facevamo a raccontare loro, se anche noi siamo circondate? E provo molta vergogna.