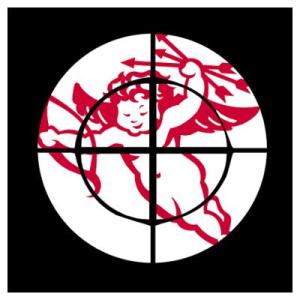Ecco qui (scorrendo dal basso) le puntate precedenti.
Alcuni nomi e fatti sono stati alterati per questioni di privacy, ma le cose sono andate più o meno così.
Ultimatum

Non conosco più le regole.
Lui “passa” da me, si emoziona, mi emoziona. Ci sono le risate e il cibo condiviso, la passione e il sonno. Poi capisco dal suo silenzio che sta per andare. Prima di uscire si infila gli auricolari, e io divento rumore di fondo. Lo dice anche lui: finché sta con me, sta bene. Poi scivolo via dalla sua giornata, e non sa come impedirlo.
Una sola volta non mi ha resistito: eravamo allo Spazio, io esibivo un taglio nuovo e indossavo un vestito di marca, appena comprato in offerta. Lui aveva avuto una brutta giornata, di quelle che ti fanno credere di essere fuori dal mondo. Voleva sentirsi normale. Continuava a dirmi che ero proprio carina, quella sera. Mi ha abbracciata tra i sacchi della spazzatura che ci eravamo offerti entrambi di buttare, andando via insieme. Non l’avevo mai visto così, non in strada, davanti ai passanti. Mentre mi rannicchiavo tra le lenzuola e la sua pelle odorosa di cibo, l’ho scoperto a fissarmi con un sorriso benevolo: ero così “brava”, mi ha detto, che avrebbe voluto che tutti gli altri mi provassero. Anche stavolta non si è spiegato le mie lacrime improvvise, e si è affrettato ad abbracciarmi: il suo voleva essere un complimento, autentico. Gli dispiaceva che l’avessi presa così, quando ero con lui dovevo sentirmi sempre a mio agio.
C’è un rituale che ormai accompagna le nostre rotture: prima di infilarsi gli auricolari mi dà tre baci, i primi due sulle guance e l’ultimo, più lento, sulla fronte. Lui si sente molto nobile nell’addio: sta facendo la cosa giusta, si ripete, a costo di non battere chiodo per chissà quanto. Poi torna a “passare”, e io non lo mando via. Non lo so fare più.
Gli sembra normale questa roba?
Questo gli scrivo, dopo che mi ha piantato di notte sulla Rambla per preparare una salsa piccante. Quello che non gli scrivo è che ho cominciato anch’io a paragonarmi alle altre. Per strada, nei negozi, le osservo una a una e mi dico: “Questa gli piacerebbe più di me, questa no”. È un vizio che non mi abbandonerà mai per davvero, che tornerà nei periodi più agitati. Per sentirmi più sicura mi “faccio bella” con due soldi, vado spesso da Kiko e nelle catene di parrucchieri a buon mercato (una volta gli è piaciuto il mio ritorno al biondo scuro, quasi castano). Cerco vestiti di seconda mano che mi evidenzino i “punti forti”, e facciano sparire il resto. Mi ripeto che lo faccio per me.
I complimenti altrui non mi saziano. L’unica a rimanere perplessa dal mio cambiamento è la Divina: quella troppo bella perché Bruno la aggiungesse a Facebook in contemporanea con me. A una serata di danze brasiliane mi squadra i capelli dalla tinta giallastra, sbagliata da una parrucchiera inesperta. Non mi dice niente, ma mi arrabbio lo stesso: non siamo mica tutte bellissime al naturale, come lei! Sulla Rambla i turisti ubriachi mi chiamano Shakira o Lady Gaga, a seconda di come mi sia pettinata, e quasi mi diverte l’idea di rievocare donne così diverse.
Ma di questo a Bruno non scrivo nulla.
La sua riposta al mio sfogo arriva la sera successiva: non riesce a vederci come coppia, sta provando a capire perché. C’è ancora la nobiltà di quando parla di chiudere, privandosi dell’unica “occasione” sicura, ma la chiosa è ambigua, come se lasciasse a me l’onere dell’ultima parola.
Lo contatto all’istante: e quindi? Non ho capito, che vuole fare? Va fuori dai gangheri. Sapeva che gli avrei scritto proprio in quel momento! Sta per uscire ed è già in ritardo, lui che mi fa aspettare anche due ore quando l’appuntamento ce l’ha con me. E poi non può spiegarsi meglio, va bene? Non sa come farlo. Capisco che si sente molto generoso, a parlarmi ora che dovrebbe solo scappare. È tutto preso da quell’impegno più urgente di me.
Ripenso alla storiella della rana nella pentola: se questo schifo fosse successo solo un mese prima, gli avrei riso in faccia e l’avrei cancellato dalla mia vita. Ora non ci riesco. Con Bruno non è mai tutto orribile, né tutto fantastico: c’è sempre la giusta miscela che lo fa tornare, che mi fa aprire la porta da cui lui uscirà con gli auricolari a palla, riducendomi a un rumore di fondo.
Chissà se mi fa una colpa anche di questo, della mia incapacità di bastargli.
Io invece sono nelle sabbie mobili. Non voglio credere di aver perso tutto questo tempo, e allora aspetto, e ne perdo ancora di più.
Ma ora so cosa succederà. Bruno tornerà presto a “passare”, e una sera saremo allo Spazio, e i Morti di Figo lo stuzzicheranno con domandine su questa o quella ragazza. Lui darà il suo “parere tecnico” proprio davanti a me, a quella che avrà finto di incontrare giusto sotto il portone, un’ora dopo averle lasciato dei lividi addosso.
Allora qualcosa in me si incepperà.
Quando succede tutto questo, è l’ultima volta che fuggo. Per arrivare a casa imbocco scorciatoie, evito i passanti sulla Rambla senza esimermi dal dare giudizi: questa gli piacerebbe, quella no.
Una volta a casa, il messaggio che mando a Bruno è un ultimatum.
Lo rivedrò solo se stiamo insieme, davvero. Se accetta mi invitasse a cena da lui, per una volta. Altrimenti gli basta non rispondere, e sparirò dalla circolazione.
Quando mi arriva il suo messaggio è tardi, e io vorrei solo dormire. Mi devo calmare un bel po’, prima di leggere.
A mercoledì per il seguito!
Se vi piace ciò che scrivo, date un’occhiata al mio Sam: non glielo ricordate, ma ha vinto un premio proprio figo.