 Una volta ce l’avevo io, adesso mi sa che tocca a voi.
Una volta ce l’avevo io, adesso mi sa che tocca a voi.
O meglio, la “pelle fina” (espressione che in più lingue denota un’alta suscettibilità) devono avercela quelli convinti che, se penso che il culo di un’attrice non dovresti imburrarlo “a sorpresa”, sto insinuando anche che hai le capacità di regia di mio cugino al filmino della comunione. Oppure ce l’ha quella che a cena, l’altra sera, mi ha spiegato che ci sono due femminismi: il suo e quello finto (tipo il mio). Infatti la prostituzione va abolita e quella femminile è “una questione di classe”. Ne deduco che la condizione della regina Elisabetta sia equiparabile a quella della mia barista lesbica coi capelli afro. Ma non ho osato chiedere.
E io? Su Facebook raccontavo la mia crisi a uno sconosciuto reduce da una rottura, e un tizio ha commentato: “Dagliela, così state meglio entrambi”. Non sono più abituata a questo genere d’ignoranza: i miei alunni catalani, che sono ingegneri e non studiosi di genere, fanno notare loro a me quando un paragrafo del libro di testo è sessista. Comunque ho commentato che al massimo “lo prendo”, e se si sente generoso ci pensasse lui, la vita è piena di scoperte inaspettate. Poi ho disattivato le notifiche dell’intera pagina, il tenore era quello e ho di meglio da fare.
Cosa? Quasi sempre, il minimo indispensabile: se il New Yorker la pensa come me su quella storia del burro (che peraltro non ho mai esternato!), basta prendere le distanze dall’italiana offesa che… “tanto-voi-ci-avete-Trump” (tempo impiegato: tre minuti d’orologio). O basta spiegare alla mia nuova maestra di femminismo – quella della regina Elisabetta – che qualcosina ne saprei anch’io (tempo: dieci secondi), prima di girarmi dall’altra parte e godermi la serata.
Per farla breve, devo proprio riesumare un classico di qualche post fa:

Segnalo anche l’analisi di un classico del tutto diverso, Radio Ga Ga dei Queen, su cui non ho affatto la pelle fina: oggi non amerei il gruppo con l’intensità dei miei dodici anni! Però il mio maestro di canto preferito osserva che quel domatore di folle che è stato Freddie Mercury eseguiva alla perfezione tutte le tecniche del mestiere, senza mai chiedersi: “Come sto andando?”. Lui era lì, nella canzone, nei movimenti, nell’interazione con pubblico e gruppo: allora il suo corpo (temprato da anni di pratica) lo seguiva con gli strumenti adeguati per portarlo dove voleva.
Ecco, forse dovremmo smettere di concentrarci sulla nostra esibizione e focalizzarci sulla causa: la difenderemmo meglio. Poi, con il tempo e l’energia che avanzano, potremmo davvero dedicarci a noi.


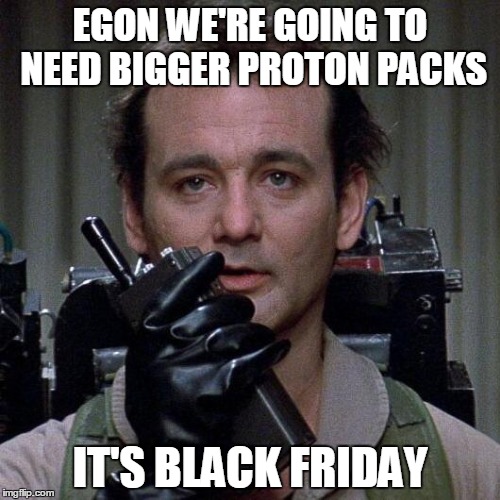
lBQNk2Bs68!~~/s-l300.jpg) Era chimico. Quello che ho affittato ai francesi (e alla loro cagnolina) insieme all’altra ala di
Era chimico. Quello che ho affittato ai francesi (e alla loro cagnolina) insieme all’altra ala di 
 Per la prima volta dopo vent’anni, devo ammettere una cosa: il mio professore di chimica aveva ragione. Va bene che ero un’adolescente problematica, traumatizzata da un liceo classico fatto di raccomandazioni e genitori arrivisti, ma se mi faceva la domanda “Cosa sono i mitocondri?” (ovvio che insegnava anche biologia), e a me veniva un infarto piuttosto che rispondere… beh, lui era lì per insegnare, e non per fare lo psicologo, aveva un registro da riempire di voti e un numero massimo di giustificazioni da offrire. Quindi potevo serbargli tutto il rancore del mondo, ma nel nostro rapporto poco poetico, fondato su cosa fossero i mitocondri, a un certo punto dovevo pur conoscere la risposta.
Per la prima volta dopo vent’anni, devo ammettere una cosa: il mio professore di chimica aveva ragione. Va bene che ero un’adolescente problematica, traumatizzata da un liceo classico fatto di raccomandazioni e genitori arrivisti, ma se mi faceva la domanda “Cosa sono i mitocondri?” (ovvio che insegnava anche biologia), e a me veniva un infarto piuttosto che rispondere… beh, lui era lì per insegnare, e non per fare lo psicologo, aveva un registro da riempire di voti e un numero massimo di giustificazioni da offrire. Quindi potevo serbargli tutto il rancore del mondo, ma nel nostro rapporto poco poetico, fondato su cosa fossero i mitocondri, a un certo punto dovevo pur conoscere la risposta. Figurarsi essere donna! Ma oggi, a cento anni e un giorno dalla fine della Grande Guerra, vorrei spezzare una baionetta a favore di chi è ancora chiamato “in trincea” (ormai un non-luogo carico dei significati più bislacchi) in nome di una mascolinità che non esiste. E no, se non esiste non bisognerebbe inventarla, anche perché è tutta lì fuori, un copione da imparare a pappardella finché “i miei uomini”, amici parenti amanti e…
Figurarsi essere donna! Ma oggi, a cento anni e un giorno dalla fine della Grande Guerra, vorrei spezzare una baionetta a favore di chi è ancora chiamato “in trincea” (ormai un non-luogo carico dei significati più bislacchi) in nome di una mascolinità che non esiste. E no, se non esiste non bisognerebbe inventarla, anche perché è tutta lì fuori, un copione da imparare a pappardella finché “i miei uomini”, amici parenti amanti e… 
