
‘O sapevate? La CUP canta l’inno col pugno alzato. Da: https://www.thetimes.co.uk/article/eu-rebuffs-catalan-leaders-as-they-are-accused-of-rebellion-2pqjg3s2c
“Comunque vada, ho perso io”: questo spiegavo ieri a chi mi chiedeva lumi sulla questione catalana.
Intanto toccavo con mano l’approssimazione italiana nel riferire della situazione, con un picco importante: un tizio che da Mannoni tesseva le lodi di Inés Arrimadas di Ciutadans. La stessa che nel suo intervento il giorno della “finta dichiarazione” ha cacciato un cuore con tre bandierine (catalana, spagnola ed europea), e ha dichiarato che il suo, di cuore, fosse abbastanza grande da contenerle tutte e tre. Non si sa invece come stia messo il suo cervello, e quello dell’altro frontman Albert Rivera, se saranno mai abbastanza grandi da superare il loro inesorabile qualunquismo o, in spagnolo, cuñadismo.
Ma era ovvio che i voti di chi era stufo di indipendentismo andassero a lei: in Catalogna o sei pro o sei contro l’indipendenza, i miei Comuns non se li caca nessuno. Ultimamente nemmeno io, da quando l’alleato Pablo Iglesias se n’è uscito che l’indipendentismo ha risvegliato il fascismo in Catalogna (dunque se l’è cercata?).
Insomma, avevo chiaro che, chiunque vincesse, perdevo io. Perché non sono indipendentista, non sono cuñada, e vorrei vendere casa.
E casa mia dietro la Rambla in questo momento non la vuole nessuno, perché se la fanno tutti addosso per la situazione politica.
Almeno l’Universo, direbbe l’amico yogi del post precedente, mi ha accontentato nel desiderio non fomentare la speculazione: gli avvoltoi stanno cercando nuovi lidi da spolpare. Ma mi pare che la gentrificazione abbia ricevuto una battuta d’arresto per i motivi sbagliati.
Di una cosa sono sicura: la Catalogna non è a mia disposizione. Questo almeno ce l’ho più chiaro di tanti italiani che sono venuti a Barcellona con soldi da investire, e che ora sono solo indignati per i guadagni che starebbero perdendo. Come se il posto che hanno scambiato per la gallina dalle uova d’oro dovesse perdere la sua storia, i suoi problemi sociali, le sue lotte più o meno condivisibili perché ehi, adesso c’è il loro baretto col Kimbo macinato fresco (magari, in genere è Lavazza). Come si permette questa gente fanatica dal “dialetto” incomprensibile di avere una vita al di fuori di quello?
Io so da un po’ che il mondo non mi gira intorno, e attendo serena di scoprire quando e come venderò una casa che, dimezzandomi le spese, mi ha permesso di scrivere otto romanzi in quattro anni: anche se non me li dovessero mai pubblicare, tutto quello che volevo fare era scriverli. Ma questa casa ormai mi porta solo crolli improvvisi, liti condominiali, e meno soldi dell’affitto che pago.
So che è già un lusso e un privilegio avere una casa da vendere, mentre c’è gente che si vede proporre l’indipendenza come panacea per sfratti e disoccupazione, e per gli eterni problemi che abbiamo noi migranti di ogni classe sociale coi documenti (tanto noi non abbiamo diritto al voto).
Comunque vada ho perso io. Ho vinto solo un biglietto per scoprire sulla mia pelle, molto più protetta di altre, come andrà a finire questa storia, e intanto mi saltano fuori nuove lezioni d’italiano.
Comunque vada l’italiano a Barcellona continueranno a impararlo (anche perché l’Italia possiede diverse aziende spagnole, ci avete fatto caso?). E continueranno a imparare le altre lingue, e gli stranieri saranno sempre benvenuti, o non meno graditi che altrove (l’Italia, per esempio).
Questa è una cosa che, nella foga di paragonare questa telenovela con le realtà che conosciamo, non ci entrerà mai in testa.
(Una gloria catalana)






 Sto perdendo la memoria.
Sto perdendo la memoria. Ciao, sto ancora cercando di salvare capra e cavoli delle
Ciao, sto ancora cercando di salvare capra e cavoli delle 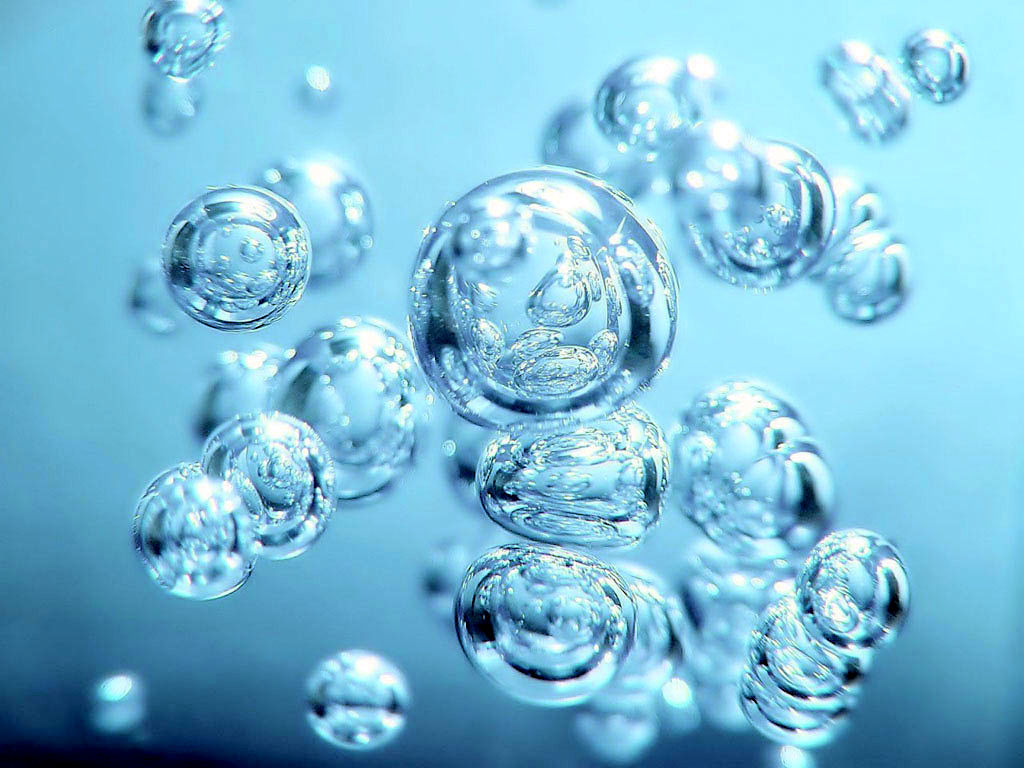 Ho mandato a monte la riunione di condominio.
Ho mandato a monte la riunione di condominio.